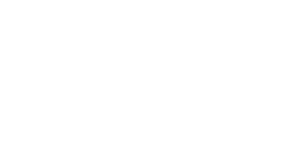Cosa ha ispirato quel vorticoso sottofondo in cui flauti, oboi, violini, viola e organo s’inseguono in continuo divenire come fossero stelle luminose nel cielo? È possibile che quella composizione musicale chiamata «Passione secondo san Giovanni – BWV 245» sia arrivata intatta ai giorni nostri e faccia vibrare le corde dell’anima come capitò a chi la ascoltò per la prima volta nella Chiesa di San Nicola a Lipsia il 7 aprile 1724, ben trecento anni fa? Da dove nasce l’Herr, il grido drammatico con cui il coro invoca il Signore e l’uomo rivela tutto il suo amore e tutte le sue debolezze?
Ci si stupirebbe a pensare che il diretto interessato, Johann Sebastian Bach, potrebbe rispondere dicendo che «il mio segreto è questo: lavoro incessante, analisi, riflessione, scrittura e infinita autocorrezione». Secondo diverse fonti, sarebbero parole sue. I biografi sembrano confermare: nella mitica Storia della musica di Massimo Mila, l’autore ricorda come la vita di Bach era quella di un onesto e laborioso organista tedesco della Germania settentrionale, condita da una robusta fede religiosa.
In effetti, Bach discendeva da una famiglia di musicisti professionisti. Tutte le sue opere rispondevano a uno scopo preciso, variabile in base alle sedi in cui lavorava o come organista o come maestro (da Weimar a Köthen fino a Lipsia). Due mogli e una ventina di figli potrebbero essere sinonimo di dissipazione, ma la sveglia alle sei del mattino per tutti e il raduno intorno al clavicembalo per iniziare la giornata cantando un inno di grazie al Signore potrebbero significare il contrario.
Eppure, per Bach la quotidianità fatta di quiete e metodo non era il punto di arrivo, bensì quello di partenza. Perché gli permetteva di andare oltre al proprio spazio e al proprio tempo. Gli permetteva di realizzare quella esigenza che solo il testo della «Passione secondo san Giovanni» sa esprimere: «Grande Re, Re grande ed eterno, come posso diffondere il tuo credo in misura bastante?», si domanda il coro, «se la mia intelligenza già stenta a trovar un paragone alla tua misericordia, potranno le mie opere ripagare i tuoi atti d’amore?».
Ecco come la musica, da eredità familiare e lavoro con cui sfamare i figli, si trasforma in altro. J.J. erano le lettere incise su tutti i frontespizi delle partiture di musica sacra di Bach: Jesu, Juva! (Gesù aiutami!). La musica diventa autentica passione, radicata nella giovinezza di un compositore autodidatta, nello studio e nella riflessione solitaria, culminata in sfida quotidiana dove scrivere fughe e inseguire contrappunti significa tendere alla precisione della geometria e alla beatitudine dell’architettura divina. Partendo dall’umanità, accarezzando lo spirito, osando alla spiritualità, Bach segna l’inizio e la fine, raggiunge il fine, tocca la perfezione.
Obiettivo tattico: realizzare melodie sempre nuove che, in armonia, funzionassero l’una accanto all’altra. Obiettivo strategico: non soccombere al cambiamento culturale del diciottesimo secolo che, per la musica, si sarebbe tradotto nel successo del melodramma e nel tramonto temporaneo dello stile contrappuntistico, mentre, in senso più ampio, avrebbe comportato il successo dell’Illuminismo, la supremazia dell’uomo e il lento declino della centralità di Dio.

Il risultato è strabiliante: la musica di Bach, svalutata dopo la sua morte, torna a trionfare con la rivalutazione della religione da parte del Romanticismo. Persino gli atei lo esaltano. Emil Cioran, filosofo rumeno, nel libro Lacrime e santi, scriverà: «Quando ascoltate Bach, vedete nascere Dio; la sua opera è generatrice di divinità. Dopo un oratorio, una cantata o una Passione, è necessario che Egli esista. Altrimenti tutta l’opera del Kantor non sarebbe che un’illusione lacerante. E pensare che tanti teologi e filosofi hanno sprecato notti e giorni a cercare le prove dell’esistenza di Dio, dimenticando la sola!».
Perché la musica di Bach è ricerca di Dio e simbolo di fede che parla innanzitutto all’anima dell’uomo e quindi alla comunità. Per farlo, egli non fa affidamento solo a sé stesso. Molti parlano del principio di imitazione: nella composizione bachiana un posto rilevante è occupato dall’intuizione, processo di conoscenza, percezione e attuazione che richiede approfondimento e sensibilità.
Bach faceva continui riferimenti al repertorio di melodie popolari sacre e profane tramandante dal Medioevo. Nel caso delle Passioni egli prese spunto dall’oratorio italiano, dove la lettura liturgica veniva fatta presso l’altare da più persone. E di Passioni Bach non ne compose due, bensì cinque: purtroppo, le uniche ad essere arrivate intatte sono solo quelle secondo Giovanni e Matteo perché ereditate dal figlio Karl Philipp Emanuel, mentre le altre tre furono perdute dal figlio Wilhelm Friedemann.
Così, pur non essendo mai uscito dalla Germania, Bach attinge alla sterminata conoscenza della letteratura musicale per arrivare a tutti e per occuparsi di tutti i generi musicali in uso al suo tempo, fatta eccezione per il teatro. Perché, secondo la sua idea, avere fede in Dio significa avere fiducia nell’uomo. D’altronde, non è un caso che il compositore della musica delle sfere celesti sia passato alla storia col soprannome di «quinto evangelista».
L’Osservatore Romano – 5/4/2024